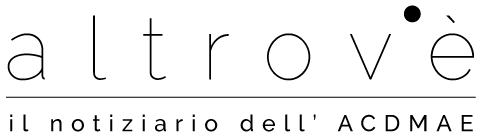di Elena Schenone Alberini
Materia da plasmare e testimoni di una storia geologica lontana nel tempo, le pietre hanno da sempre affascinato gli uomini perché simbolo di eternità. E proprio le pietre sono protagoniste di una mostra che, nelle sale della Galleria Borghese, raccoglie oltre sessanta opere fra dipinti ed altri oggetti il cui nucleo centrale appartiene alla collezione che il Cardinale Scipione Borghese, nipote di Paolo V, mecenate delle arti, poliedrico ed appassionato collezionista, aveva riunito nei primi tre decenni del Seicento.
Le curatrici Francesca Cappelletti e Patrizia Cavazzini avevano iniziato a studiare le opere presenti nei depositi della Galleria Borghese durante la chiusura del museo imposta dalla pandemia, prima che i restauratori le riportassero allo splendore originale restituendo oggi al pubblico dei capolavori che non possono che suscitare incanto e stupore.
Altre opere esposte sono invece costituite da prestiti eccezionali provenienti da musei italiani, stranieri e da collezioni private. Tra queste risalta lo stipo Borghese-Windsor (1620), una chiesa in miniatura decorata con intarsi di pietre dure in cui spiccano i lapislazzuli che creano un effetto cromatico scintillante, e con settantaquattro cassetti segreti. Il mobile, già di proprietà Borghese, fu acquisito da Giorgio V nel 1827 e venduto all’asta da Elisabetta II nel 1959. La pratica, molto diffusa nel seicento, del fedecommesso testamentario, invece, permise a molte di queste collezioni di restare integre per generazioni in mano ai proprietari e mantenere i nomi delle famiglie alle quali sono legate.
La tecnica della pittura su pietra, già citata da Plinio in tempi antichi, venne riscoperta da Sebastiano del Piombo dopo il Sacco di Roma che, nel 1527, aveva provocato devastazioni e danni irreparabili in città, e messo in fuga la comunità artistica. Quando, nel 1530, il pittore rientrò in città si cimentò in questa tecnica illudendosi che la pietra, inalterabile e perenne, potesse rendere eterna anche la pittura. Il successo e lo sviluppo della pittura su pietra vanno anche associati alla passione del tempo per i marmi antichi policromi, ad emulazione della magnificenza degli imperatori romani, e per le pietre dure, semipreziose e venate, come l’alabastro e l’agata. Roma era diventata una cava a cielo aperto, dove si erano accumulati i marmi importati dagli angoli più remoti dell’impero grazie a una delle più grandi operazioni logistiche della storia. Gli antichi, ad esempio, estraevano il porfido rosso da un’unica cava nel deserto egiziano, lo trasportavano grezzo lungo il Nilo fino ad Alessandria dove veniva lavorato, e poi proseguiva il viaggio fino a Roma. Qui era stato inizialmente impiegato in architettura e scultura, ma poi servì per raffigurare i sovrani ed il loro carattere divino. E così avvenne anche durante il Rinascimento: nel ritratto su porfido di Cosimo I de’ Medici (1560), le qualità morali del granduca si identificano con le caratteristiche della pietra, alludendo altresì alla solidità e longevità del suo governo.
Nelle botteghe del tempo, frequentate da una clientela ricca e raffinata, lavoravano anche maestri specializzati nella creazione di oggetti d’arredo: il tavolo intarsiato in esposizione, probabilmente appartenuto ad un “commesso” del cardinale Francesco de’ Medici, ha come piano un grande ovale di alabastro centrale, inserito in una piastra di marmo nero antico decorata con fiori e geometrie tipiche della manifattura romana del ‘500.
Le fonti testimoniano di come famosi artigiani ed architetti si alternassero nei diversi cantieri delle cappelle gentilizie e degli interni dei palazzi nobiliari, e di come l’acquisto di pietre di grande valore, ricercate su scala europea e globale, contribuissero a creare connessioni tra diverse culture. Non stupisce quindi se, nel 1724, Benedetto XIII decise di includere numerosi oggetti in pietre rare e dei quadretti in pietre naturali tra i doni diplomatici da destinare all’imperatore cinese e se anche nella collezione Borghese, nel 1693, giunse un quadretto su pietra che ritrae un cardinale rosso, volatile di origine americana, a testimoniare un gusto esotico già molto diffuso.
Gli artisti, ben pagati, esaminavano le venature dei campioni litici e stabilivano quali soggetti fossero più adatti ad essere rappresentati, trasformando la materia in opera d’arte: le venature diventavano squarci di nuvole, rocce, colline, onde. Antonio Tempesta, ad esempio, realizzò diverse opere su pietra paesina mettendo in risalto con pochi tocchi di pennello i bizzarri paesaggi naturali che i frammenti di calcare e manganese avevano lasciato nella pietra. Esperto incisore, creava soluzioni compositive originali per opere quali “La presa di Gerusalemme”, “Il passaggio del Mar Rosso”, “La vocazione di San Pietro”. L’alabastro invece veniva dipinto su entrambi i lati per esaltarne la capacità di catturare la luce, il cui passaggio attraverso la pietra era metafora dell’incarnazione di Cristo e della discesa della luce divina nell’anima del fedele: guardare le scene dipinte sulle icone devozionali aveva effetti benefici sul corpo e sull’anima dell’osservatore. Specifiche pietre con proprietà curative ed apotropaiche erano poi usate per monili e talismani protettivi.
Una sezione della mostra accende inoltre i riflettori sull’uso della lavagna e della pietra di paragone. La lavagna, “l’oro nero della Liguria”, era la pietra più utilizzata per le pale d’altare e i ritratti perché giudicata adeguata a rappresentare diversi significati metaforici e teologici.
Sulla pietra di paragone, usata per testare la veridicità dell’oro, erano invece dipinte scene notturne in cui risaltavano i rossi e gli ori. Le pietre nere erano spesso lucidate con cura perchè vi si riflettesse l’immagine dello spettatore, che così si sentiva parte integrante della scena rappresentata.
Questa “moda” durò circa un secolo e declinò nella metà del Seicento, quando gli artisti si resero conto di come la pietra non fosse davvero indistruttibile: poteva rompersi ed incrinarsi, ed era anche vittima dell’umidità. Le pietre persero allora il loro incanto e si preferì impiegarle, frantumate, in pozioni miracolose per scongiurare gli effetti della peste che si stava diffondendo in Europa. L’arte della pittura su pietra quindi perse un po’ della sua luce ma non cadde mai nell’oblio: nei secoli, ha continuato ad esercitare il suo fascino fino ai giorni nostri. E’ “la meraviglia senza tempo” che ci regala questa mostra a ricordarcelo.
Elena Schenone Alberini

Nata a Genova e cresciuta a Roma, si è laureata in Scienze Politiche alla Luiss. Ha vissuto in Libia, Stati Uniti e Turchia. Si è dedicata con passione alla ricerca, approfondendo in particolare i suoi studi etnografici. Dopo la missione del marito a Tripoli pubblica una monografia sulla simbologia dei monili berberi del Nord Africa, “Libyan Jewellery a Journey through symbols” (Araldo De Luca Edit, 1998). Si interessa di formazione e comunicazione interculturale, arte e scrittura. E’ consigliera ACDMAE e con pazienza sta curando i nostri archivi storici, oltre a ricoprire la carica di Tesoriere.