di Carlotta Sertori Scopa
Tokyo si è portata via quattro anni delle nostre vite in un battito di ciglia. In Giappone il tempo, seppur cosi scandito dal ritmo regolare delle stagioni, da feste e tradizioni rigorosamente celebrate da grandi e piccini, sembra aver messo il piede sull’acceleratore.
Si potrebbe pensare che la colpa sia dei ritmi frenetici a cui si è sottoposti vivendo in una megalopoli di 15 milioni di abitanti, che diventano 35 se si considera la “Grande area metropolitana”, ma non è così, perché la capitale dell’Impero del Sol Levante è una città a misura d’uomo… e di bambino.
Un posto dove puoi tranquillamente girare in bicicletta, con un bimbo piccolo seduto sul seggiolino, senza correre alcun pericolo. L’unico rischio è quello di imbatterti in una mamachari: la station wagon delle bici elettriche a pedalata assistita, che si sposta ondeggiando, carica di mamme, bambini, borse, zaini e a volte anche cani o gatti così agghindati da sembrare finti.
A Tokyo mi sentivo a casa. Io, cresciuta in un paesino di 2000 anime, ogni mattina attraversavo l’incrocio di Shibuya, il più trafficato del mondo, dove passano migliaia di persone al minuto, milioni al giorno, dove tutto è un groviglio magico di automatismi. Nessuno spinge, nessuno si urta, nessuno cade. Pedoni, passeggini, biciclette e ombrelli si intrecciano magicamente come nello schema di un video gioco.
Poi giri l’angolo e ti trovi immersa nel verde di un parco con alberi secolari, tempietti e altari, migliaia di ciliegi, che nella settimana di sakura diventano i sovrani incontrastati della città, vecchietti che passano ore intere a fotografare una foglia o un fiore, signore solitarie che fanno ginnastica e la fantastica magia del silenzio.
La città non è così moderna come si potrebbe pensare, ma tutto è conservato bene. Manca quella modernità sfacciata e ostentata tipica di molte altre megalopoli asiatiche. Trenta anni fa Tokyo doveva essere il futuro. Immagino un’atmosfera quasi surreale: i primi treni super veloci, una metropolitana che ti porta ovunque, insegne luminose coloratissime, biglietterie elettroniche, macchinette dappertutto… oggi tutto è consolidato e questo ti coccola e ti rassicura.
La microcriminalità di fatto non esiste e la gente si sente così sicura da mandare bambini di 6 o 7 anni a scuola da soli, anche a km di distanza. E’ bellissimo prendere il treno e beccare una scolaresca in uscita. Un piccolo esercito in divisa: ufficiali e marinarette, bermuda, minigonne e calzettoni anche d’inverno, zaini in cuoio pesantissimi e cappellini colorati, che identificano l’età o la scuola di appartenenza. Sembra di essere dentro uno di quei cartoni animati che tanto ci hanno fatto sognare da bambini.
All’asilo nido di mio figlio, una scuola semi internazionale ad impostazione giapponese, eravamo considerati un po’ esotici, essendo tra i pochi “gaijin” (termine un filino irriverente con cui i giapponesi indicano gli stranieri) a frequentarla. Qui il pranzo si porta categoricamente da casa. Si prepara il famoso “Bento”, disponendo il cibo in un contenitore a scomparti dalle forme più assurde. Noi alternavamo un camion dei pompieri con tanto di pilota, sirena e scaletta al faccione rassicurante di Totoro, il protagonista di un famoso anime di Miyazaki.
Pensi di aver fatto lo sforzo più grande del mondo: ti sei alzata presto, hai preparato tutto diligentemente e sei pure soddisfatta del risultato, salvo sentirti morire quando gli altri bimbi sollevano il coperchio del loro “bento box”. Vorresti seppellirti sotto ai tuoi fusilli al pomodoro, che a mezzogiorno sono inevitabilmente scotti e freddi, quando vedi la perfezione di quelle palline di riso che ti sorridono, l’uovo sodo decorato così bene da sembrare animato, un pomodoro tagliato come fosse un diamante.
Le mamme che si alzano alle 6 a preparare questi capolavori per i loro bambini ti guardano strano. Sono gentili e ossequiose, i complimenti si sprecano, ma tu rimani sempre una “gaijin”, una di quelle mamme che ingolfa il figlio di carboidrati, che invita gli altri bimbi a giocare a casa senza il canonico mese di preavviso, che fa le torte da sola. Quella che che il primo giorno ha parcheggiato la macchina con le 4 frecce sotto la scuola e che si è pure meravigliata di trovarsi una multa per procurato allarme, con tanto di macchina della polizia lì ad attenderla.
Ma soprattutto ha generato grande ilarità la mia richiesta di fare una sorta di inserimento graduale al nido. La direttrice per tutta risposta ha preso il mio piccolino, l’ha buttato in braccio a una maestra come fosse un sacco di patate e mi ha detto “Ci vediamo alle 14.30”. Il risultato? Dopo 3 giorni di disperazione assoluta ha smesso di piangere e non ha più versato più una lacrima, nemmeno nelle nuove scuole.
La nostra seconda bimba è nata a Tokyo, in una clinica che per le mamme sembrava un hotel a cinque stelle. Un minuto prima di partorire una zelante infermiera continuava a chiedermi se la mattina dopo avrei preferito la colazione internazionale o giapponese. Credo di averle urlato le peggio cose, ma lei rimaneva lì, in attesa di portare a termine il suo compito. Tuttavia, anche qui, regime militare per i neonati: una sveglia rumorosissima piazzata sotto la culletta li fa sussultare ogni 3 ore per la poppata. Ovviamente la mia richiesta di disinnescare la bomba è rimasta inascoltata e il netto rifiuto di togliere l’allarme è stato mascherato da sorrisi e frasi gentili… alla fine hanno vinto loro… come sempre del resto…
Scherzi a parte, vivere questa avventura con due bimbi piccoli è stato per alcuni versi meraviglioso, anche e soprattutto grazie ai nostri “nonni giapponesi”. Si, perché noi abbiamo avuto la più grande fortuna che possa capitare a uno straniero in Giappone, vale a dire quella di poter frequentare assiduamente una famiglia giapponese. Daisuke-san, un vecchio amico di mio marito dei tempi dell’università, e i suoi adorabili genitori ci hanno aperto le porte della loro casa. Abbiamo trascorso insieme tutte le feste tradizionali bevendo sake e giocando a piedi nudi sul tatami, preparato insieme i pranzi della domenica, mangiato cose squisite che non si trovano nei ristoranti e quando tra di noi si sovrapponeva l’ostacolo della lingua bastava un sorriso o un piccolo inchino per superare l’impasse. Ci portavano borse di frutta e verdure fresche all’uscita di scuola, si offrivano come baby-sitter, ci hanno ospitato nella loro casa sulle montagne, ma soprattutto ci hanno insegnato tanto sulla vita quotidiana e dato gli strumenti per capire, o quantomeno cercare di capire, un popolo che ha tanto da dire e da raccontare, una volta superata la barriera che erige, un po’ per diffidenza, un po’ per autodifesa.
Ancora oggi quando arriva un pacco dai nonni Umehara è festa grande. Mandano ad ognuno di noi le nostre cose preferite, che tanto ci ricordano i bei momenti passati insieme: sembei (deliziosi salatini di riso e salsa di soia, ottimi con la birra), curry, mini riproduzioni di treni supersonici e adorabili pupazzetti. Il tutto impacchettato a regola d’arte, al punto che quasi dispiace aprire la confezione… ma poi si sa, la curiosità ha sempre la meglio.
Il nostro prossimo appuntamento con il Giappone sarà Tokyo 2020, per le Olimpiadi. Si, perché ho promesso ad un simpatico tassista ultra-ottantenne, preoccupatissimo perché doveva studiare inglese su un libretto distribuito dal governo in modo da essere pronto ad accogliere i turisti, che sarei tornata ad interrogarlo!
Carlotta Sertori Scopa

Laureata in scienze politica con un master in International Affairs, ha lasciato il suo lavoro in consulenza aziendale per seguire il marito prima in Azerbaigian e poi in Giappone. Rientrata a Roma un anno fa ha dato vita ad un suo progetto costituendo una piccola società di relocation per le famiglie giramondo come la sua. Mamma di tre bambini piccoli ha dovuto, al momento, mettere da parte la sua passione per i viaggi e la lettura.
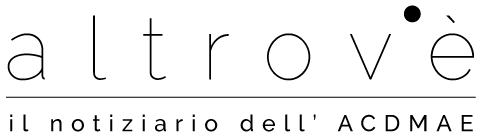
 di Carlotta Sertori Scopa
di Carlotta Sertori Scopa