di Nicole Ludwig Nicolaci
Le porte scorrevoli si aprono e il sole del mattino mi acceca. Sento l’aria calda e umida. In un attimo mi trovo circondata da centinaia di voci che gridano una sopra l’altra, confusamente. “Signora, venga, qui non esta sicuro“. Sono le uniche parole con marcato accento spagnolo che, insieme a una mano che mi fa il segno di allontanarmi, riesco a distinguere dai mille volti sconosciuti. Seguo il signore – l’autista venuto a prenderci all’aeroporto – verso la macchina blindata. Saliamo. Le porte pesanti si chiudono e, nell’abitacolo, improvvisamente l’atmosfera si distende.
“Vedi, non è stato neanche troppo complicato“, sorride mio marito, accarezzando nostro figlio di tre anni. “Benvenuta in Venezuela!” mi dice l’autista.
“Il Venezuela…“, ripeto dentro di me, per convincermi che siamo davvero atterrati in questa terra lontana e sconosciuta: è la prima missione di mio marito all’estero e l’abbiamo scelta insieme, nonostante fosse una destinazione particolarmente delicata. Avevo letto articoli sugli scontri del 2019 e sulla storia del Chavismo, e visto alcuni recenti documentari eppure ero consapevole di non sapere ancora nulla del Paese. Alla fine, mi ero detto che non si è mai preparati abbastanza per affrontare traslochi così importanti: ad un certo punto bisogna semplicemente tuffarsi nel mare aperto e nuotare.
Intanto l’auto viaggiava dall’aeroporto, affacciato sul mare, verso la Capitale, Caracas. Guardavo dal finestrino stupita per quel panorama quasi disabitato, arduo, poco invitante, roccioso.
“Come sta andando adesso la situazione pandemica?”, chiesi all’autista per iniziare a farmi un’idea concreta del luogo. “Bisogna fare molta attenzione e proteggersi bene”, mi risponde, spiegando che i numeri dei contagi da Covid vengono annunciati dal governo di Maduro, ogni settimana, sulla Televisione nazionale. Mi conferma quello che avevo saputo da mio marito: la situazione negli ospedali di Caracas è al limite e quindi è scattato il cosiddetto sistema del 7+7, cioè una settimana di lockdown totale con solo i negozi di prima necessità aperti, seguita da una settimana “flessibile“ con ristoranti, parchi pubblici e i club privati aperti.
Era il 5 gennaio del 2021 ed eravamo appena arrivati nella Capitale venezuelana. Il paesaggio roccioso aveva lasciato il posto a montagne ricoperte di vegetazione che lasciavano intravvedere la città. Sebbene il traffico fosse contenuto, come c’era da aspettarsi in piena pandemia, la prima vista di Caracas mi spaventò: tra i grigi grattacieli con minuscole finestre coperte da grate di ferro e gli edifici protetti da muri con filo spinato si distinguevano nitidamente dei raggruppamenti di casupole colorate e decadenti, simili a baracche. Erano i barrios, i quartieri poveri di Caracas, e non si trovano soltanto (come credevo) nelle periferie, ma praticamente ovunque in città. Questo, anche nei giorni successivi, mi provocò un senso continuo di spaesamento. Poteva capitare, facendo un giro in auto, d’incontrare un piccolo barrio dietro l’angolo ma i grandi barrios della periferia restavano off-limits per gli stranieri e questo rendeva ancora più difficile capire la tragedia umana, con i suoi abissi di povertà endemica, senza alcuna realistica prospettiva di riscatto sociale della società locale. Il barrio è un universo parallelo, con le proprie regole, tanto violente quanto spietate, e Caracas è come un grande mosaico disarmonico, fatto di grattacieli, barrios appunto, ruderi evanescenti dell’epoca colonialista spagnola e qualche raro quartiere “curato”, esclusivamente riservato alle persone più agiate. È una città policentrica, senza una logica strutturale, o un centro unificante, circondata però da una natura di una bellezza incontaminata, una cornice che contrasta fortemente con la creazione dell’uomo.
“Embajda de Italia!”, grida improvvisamente l’autista dal finestrino. La macchina si ferma davanti ad un grande cancello: l’Hotel Altamira Suites, la nostra sistemazione, sarebbe diventata casa nostra per i prossimi mesi. Due suites identiche e comunicanti, al 16mo piano, luminose e spaziose ma, ovviamente, non organizzate per le necessità di una famiglia. Due cucine minuscole, senza lavatrice ne’ lavastoviglie e senza acqua potabile, si affacciavano su due spazi living. Ogni suite aveva inoltre il suo piccolo bagno e la sua camera da letto e tutto era arredato in tipico stile anni’80: una, con l’immancabile moquette di color blu-verde, sarebbe diventata la nostra suite di uso famigliare; l’altra, con un pavimento di ceramica più presentabile, sarebbe diventata quella del salotto, con l’angolo lavoro di mio marito.
I primi giorni trascorsero velocemente, tra il tentativo di capire dove mi trovassi e l’emozione di essere arrivati in una nuova destinazione. Certo, la situazione pandemica non facilitava il nostro inizio a Caracas, ma ho cercato sin dal primo momento di ricreare un ambiente e un ritmo di normalità non solamente per me stessa, ma soprattutto per nostro figlio che, già dopo i primi giorni in hotel, chiedeva impaziente quando e dove poteva giocare con altri bambini. Rispondergli, a Caracas, era decisamente complicato: trovare parco giochi nel verde, uno scivolo e un’altalena diventò una vera caccia al tesoro. La situazione si era stabilizzata ma la città era comunque pericolosa, soprattutto per gli stranieri: non a caso la decisione dell’amministrazione di sistemare tutto il personale in un’unica struttura rispondeva alla necessità di minimizzare i pericoli che celava la Capitale. L’hotel purtroppo offriva limitate possibilità di sfogo specie per i più piccoli dell’ambasciata: la palestra e la piscina, ritagliata tra la strada e i palazzi, con un piccolo ristorante chiuso sempre in ristrutturazione. Fuori dal nostro cancello c’era spazio solo per le uscite indispensabili per la vita quotidiana: fare la spesa e accompagnare il piccolo alla scuola materna. Con la macchina blindata e un autista privato (lì non se ne può fare a meno) facevo questi tragitti d’obbligo per poi cominciare, poco alla volta, ad allargare i miei giri nel tentativo di scoprire la città. Si andava dal macellaio di fiducia, di origine italiana, vicino all’hotel ma anche dal fruttivendolo portoghese, posti in cui capitava anche di scambiare due chiacchiere in attesa che il pagamento – il momento clou della spesa – andasse a buon fine. La questione del pagamento a Caracas, infatti, segue una logica tutta sua. La moneta locale è soggetta a inflazione galoppante, peggio che nella Germania della Repubblica di Weimar. In più il bolivar, il conio venezuelano, non è praticamente più disponibile. Si paga dunque con i dollari americani, che hanno un valore non solo monetario, ma sono simbolo di libertà di consumo e di privilegio sociale, oppure semplicemente con il bancomat.
Nelle prime settimane Caracas mi riservò parecchie sorprese. Mentalmente mi ero preparata a una situazione di mancanza di beni essenziali, invece nei negozi alimentari si trovava di tutto, diversamente da quello che mi era stato detto. Per i prodotti freschi e di buona qualità, più difficili da reperire, era stato recentemente aperto un esclusivo supermarket di lusso, uno dei risultati tangibili della dollarizzazione dell’economia, un fenomeno che stava velocemente creando una realtà parallela a quella della vita normale venezuelana e quindi anche un forte desiderio generale di consumare beni importati. Come in una bolla surreale che abbracciava interi quartieri, generalmente considerati abbastanza sicuri, lì si poteva anche mangiare in ristoranti eleganti e fare un’ottima spesa. Erano i quartieri per le famiglie più ricche e potenti di Caracas, che restavano fra loro, vivendo una vita radicalmente separata da tutto il resto. Nei quartieri della “bolla” i nuovi esercizi commerciali aprivano a velocità incredibile: Bar, Caffè, Ristoranti, negozi di arredamento italiano e francese importato, supermercati di lusso con burro tedesco, il caffè italiano, il peanut butter americano e champagne francese, ovviamente in vendita a prezzi astronomici esclusivamente per la ristretta fascia ricca venezuelana che era rimasta in città e per la comunità internazionale.
Non sono mai riuscita ad abituarmi veramente a quella profonda “voragine” che separa i quartieri “bene” dal resto della città, dove si lotta per sopravvivere e dove lo stipendio medio non supera i 5 dollari al mese quando un antibiotico pediatrico ne costa sei. E non mi sto riferendo ai barrios, realtà che non ho neppure mai potuto visitare. Le mie mattinate, infatti, passavano facendo piccole commissioni in attesa di andare a prendere mio figlio alla scuola materna. I pomeriggi poi erano solitamente riservati a lui e alla ricerca di un parco, di un club privato aperto (impresa non facile in tempi di pandemia) o, in generale, di un programma adeguato per un bambino di tre anni.
Grazie a una piccola rete di amicizie che nel frattempo sono riuscita a costruire, la ricerca è diventata un po’ più facile. Nel gruppo c’erano consorti di altre amministrazioni e di organizzazioni internazionali e ci si sosteneva a vicenda, con spontaneità, altruismo, e dando veramente prova di solidarietà reciproca. Queste amicizie mi hanno anche aiutato a trovare un’attività conforme ai miei interessi, da svolgere gratuitamente: ho cominciato a insegnare il tedesco al Goethe Institut di Caracas.
Spesso organizzavamo anche degli incontri per noi e per i bambini che potevano così giocare in libertà nei giardini delle loro case e ville private. Il fatto di vivere in un hotel piuttosto modesto peraltro rendeva particolarmente difficile ricambiare l’ospitalità e così la vita sociale rimaneva a “senso unico”: uscivo io, oppure proponevo agli amici una colazione al ristorante. Le nuove amicizie mi hanno comunque aiutato a scoprire, ogni giorno di più, la città che, con le sue particolarità, diventava ogni giorno meno spaesante.
A distanza di mesi (N.d.R. oggi sono a Torino in attesa di un’altra destinazione) mi rendo conto che la vita in un hotel, con un bambino piccolo, non è stata facile. Per me, tuttavia, il periodo a Caracas ha rappresentato un’esperienza importante di vita ponendomi davanti a difficoltà, forse banali, ma che richiedevano ogni giorno una nuova soluzione e così mi sono anche resa conto di quanto le mie abitudini europee, ad altre latitudini, non fossero per nulla scontate.
L’esperienza di Caracas mi ha certamente fatto crescere, regalandomi uno sguardo meno ingenuo sulla sfida del trasloco e sulle mie aspettative.
Nicole Ludwig Nicolaci

Nata a Francoforte e cresciuta a Praga, si è laureata in filosofia, storia e italianistica presso l’Università di Friburgo (Germania). Dopo gli studi si trasferisce in Italia per seguire il marito nella carriera diplomatica. Nel primo periodo, a Roma, lavora come corrispondente dall’Italia per il canale nazionale all news della Repubblica Ceca, CT24.
Nel 2021 segue il marito in Venezuela. Insegna presso il Goethe Institut Caracas la lingua tedesca. Le lingue straniere e la scrittura sono due delle sue passioni. Ha un figlio piccolo.
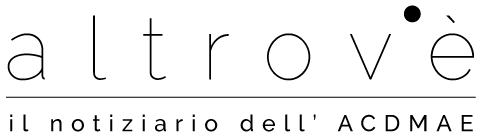





Molto interessante il tuo articolo Nicole.