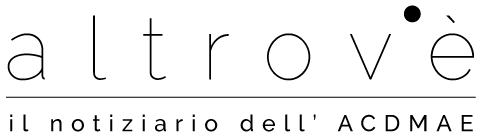di Chiara Mezzalama
Chiara Mezzalama ha condiviso l’esperienza di vita che ci accumuna, in quanto figlia di un diplomatico. Ha maturato un’attenzione ed una sensibilità particolari ed acutissime nel guardare al mondo e alle emozioni. E nel guardare dentro sé stessa. I suoi romanzi sono molto belli, in particolare “Il giardino persiano” (Ed. E/O, 2016) è una lettura che consigliamo a tutti, anche ai nostri figli che si riconosceranno nelle parole di Chiara. Altrettanto interessanti sono questi due racconti che la Scrittrice ha voluto offrire per le pagine di ALTROV’E’.
1.
Si svegliò nel cuore della notte. Il freddo lo afferrò per i piedi appena uscì dalla coperta di lana ruvida che lo avvolgeva. Si infilò un paio di calzettoni dentro gli zoccoli di legno. Nella stalla le bestie erano inquiete, una delle vacche era prossima al parto, aveva avuto una gravidanza difficile che l’aveva costretta a restare sdraiata per quasi tutta la durata dell’ingrossamento, presto il suo supplizio sarebbe cessato, ma il parto si annunciava complicato. Era una bestia mansueta, che pareva aver accettato il suo stato di semi infermità con pazienza, non scalciava, non protestava come avrebbero fatto altre al suo posto, si chiamava Asia e lui l’amava. Toni aveva visto da poco un programma in televisione sulla reincarnazione e ne era rimasto colpito, aveva subito pensato a lei, a quel suo modo di fare gentile, gli occhi carichi di una tristezza che sembrava venire da storie precedenti. Quando andava nella stalla, lei era sempre la prima a girarsi, come volesse chiamarlo a sé, e se lui si avvicinava lei piegava la testa di lato con un gesto di sottomissione che per gli animali significava amore. Mancavano pochi giorni alla luna piena, quindi ogni momento poteva essere quello buono.
Fuori il cortile era immerso in un silenzio gelato, il cielo era terso e le stelle erano in mostra nonostante la luce forte della luna. I suoi passi risuonarono secchi sul selciato, camminò in fretta per raggiungere il tepore della stalla. Il caldo e l’odore di fieno e di animale lo avvolsero come uno scialle. Le vacche dormivano tutte, tranne lei. Lei si lamentava, un lamento sommesso ma disperato, come per un dolore indicibile. La cosa peggiore era quando il vitello nasceva già morto, senza nutrimento o strozzato dal cordone. Dopo tutto il travaglio, l’animale aspettava il contatto con il piccolo, ma se il piccolo nasceva morto, la vacca si struggeva con le mammelle piene di un latte che non avrebbe potuto dare. Alcune diventavano feroci, pazze, tiravano sulla catena come a voler strappare via il cemento dell’abbeveratoio, altre si deprimevano, si lasciavano andare, spesso poco dopo si ammalavano, altre ancora diventavano lunatiche, imprevedibili, non accettavano più le regole, scappavano per i campi invece di seguire la mandria al pascolo. Asia non si sarebbe ripresa da una simile sventura, Toni lo sapeva e avrebbe fatto di tutto per far nascere bene quel vitello. Il vitello morto era cattivo segno per tutti, un brutto presagio. Se fosse andato tutto bene e nasceva femmina, l’avrebbe chiamata Martina, come il santo buono che divideva il mantello e segnava la fine e l’inizio della stagione. Si avvicinò a lei e le carezzò il ventre gonfio, le vene sporgevano come fossero sul punto di esplodere, dentro il vitello si muoveva ancora. “Lu tiruma fora, lu tiruma fora prestu, sagrinte nen” le sussurrò all’orecchio, ma non sarebbe stato quella notte, non c’erano ancora le contrazioni, “pasiensa, enta avei pasiensa”, la vacca si calmò come avesse capito le sue parole. Il lamento non era di dolore, piuttosto sembrava un bisogno di rassicurazione. Toni sentiva la sua paura. Si mise a sedere accanto a lei sullo sgabello a tre gambe e aspettò che si addormentasse.
Ormai era rimasto quasi solo, i suoi erano troppo vecchi per fare la loro parte, c’era sua madre che dava una mano, era ancora robusta e determinata ma in due non ce l’avrebbero fatta comunque. La stalla, quarantacinque capi, i campi per la paglia e il pascolo, la cascina che diventava ogni anno più decrepita, proprio come i suoi, le norme severe che regolamentavano gli allevamenti, tutto era diventato così complicato, faticoso, come se l’uomo non facesse che mettere filtri tra sé e la natura e tra sé e le bestie. Ma non si era tutti delle bestie? Nel senso buono del termine s’intende, delle creature insomma che si nasce, si campa, si soffre e si gode e poi alla fine si muore, che c’è di male a pensare la vita così? Invece no, adesso c’erano i controlli, le carte, le sterilizzazioni, le spese, ma la roba che ti davano da mangiare era sempre peggio, tutta questa fissa con l’igiene e poi ti avvelenavano lo stesso, che diavolo di senso aveva? Lui le bestie le sapeva ad una ad una, sapeva la terra in ogni sua piega, fin giù al torrente che negli anni si era fatto secco come una donna avvizzita, meno acqua per irrigare, l’inverno la neve non cadeva quasi più e ci mancava poco che gli venissero a chiudere il pollaio perché lasciavano le galline libere di razzolare nell’aia.
Le bestie dormivano, i cani dormivano, ma lui non aveva più sonno. Si alzò e uscì nel freddo della notte. Erano le tre e venti. La luna illuminava ogni angolo del cortile, pareva un paesaggio incantato. Lungo la strada provinciale passava ogni tanto una macchina che correva a gran velocità. Riuscì a leggere la frase che occupava un’intera parete della cascina: “L’Italia a mio avviso deve rimanere una nazione a economia mista con una forte agricoltura che è alla base di tutto”. Durante i restauri era stata salvata per suo volere. Era il senso del suo stare in quel luogo da quando era nato, e dei suoi da due generazioni precedenti, e lì sarebbero morti tutti. Ma per il resto chi ci credeva più a quelle parole? Erano le parole di un paese lontano come le stelle laggiù, fatto di uomini che non esistevano più. Tornò all’interno, lasciando gli zoccoli all’ingresso, le zie non sopportavano che si lasciasse per terra traccia di stalla, la stufa era ancora calda, ci infilò due ciocchi di legno per farla riprendere, si versò un bicchiere di latte e rimase seduto ad ascoltare la fine della notte, il crepitio della legna secca. Sognò una banda di ragazzi giovani, con dei secchi di vernice che imbrattavano i muri e sconciavano l’iscrizione gridando – sporco fascista -, lui nascosto tra le mammelle dell’animale, tremava di paura.
2.
“Guarda che la mezzadria è stata abolita nel sessantaquattro perché considerata iniqua”, disse la giovane donna al volante. La macchina attraversava la pianura immobile per il freddo. Le montagne dietro facevano da sfondo, come in un libro pop-up sbalzavano all’orizzonte, dando un particolare rilievo a tutto il paesaggio. Un fronte di nuvole avanzava da sud ovest, avvolgendo il cielo, l’Argentera era già scomparsa, presto tutte le montagne sarebbero sparite, come un libro che si chiude. Le piaceva quel territorio pianeggiante, così diverso secondo le giornate. Le piaceva l’inverno, quando la brina si posava su tutto trasformando il mondo in una minuziosa costruzione di cristallo, le piaceva il fumo che usciva dai camini, spesso l’unico segno di vita che si percepiva dall’esterno. Dentro sapeva che era odore di caffé e polenta e televisioni accese tutto il giorno, come in ogni altro angolo del paese. Le piaceva il suo lavoro di veterinaria per quello, andarsene in giro per campagne e cascine a guardare gli animali, seguire le stagioni, parlare con i vecchi, cercare di spiegare il perché delle procedure, la loro utilità, prelevare il sangue, analizzarlo in laboratorio. Quando tornava con il verdetto, leggeva il terrore negli occhi della gente, da lei poteva dipendere la sopravvivenza di un’intera stalla. Questo era l’aspetto spiacevole, difficile. Sapeva di essere odiata talvolta. Le piaceva far partorire le vacche, visitare i vitelli. Era una vecchia storia. Suo padre era stato proprietario di una cascina, non lontano da dove stava passando con la macchina, poi i contadini si erano fatti vecchi, la cascina era stata prima affittata, poi venduta e ora giaceva in rovina come una scarpa rotta, buttata sul ciglio della strada. La sua felicità di bambina era stata accompagnare il padre in giro per campi, lui conosceva il nome di ogni pianta e di ogni uccello. Alla fine i suoi studi erano stati soltanto un modo per dare un ordine a ciò che già conosceva.
“Ma tu credi che gliene importi qualcosa a questi contadini? L’unica differenza è tra essere proprietari e non esserlo”. Si era portata dietro Vittorio che faceva il regista e voleva girare qualcosa sul mondo rurale. Dopo tutte le storie che lei gli aveva raccontato, andando da una cascina all’altra, gli era venuta una certa curiosità per quel mondo dimenticato. Litigavano spesso sull’argomento, lui era convinto che fosse un universo definitivamente scomparso perchè snaturato, lei invece sosteneva che la terra e la sua gente nascondevano risorse inesauribili. Certo, i giovani non amavano seguire la vita dei padri, troppa fatica, troppo sacrificio, arrivava gente dell’est, romeni, bulgari, indiani che tenevano le vacche, lavoravano la terra, era in corso una grande rivoluzione che alla fine avrebbe richiamato indietro anche i giovani. “Non si trova più il lavoro in fabbrica come una volta e se alla fine non trovi niente, torni a casa, anche se ti fa schifo l’odore della merda”, disse lei aprendo il finestrino per mettersi a fumare. L’aria era fredda e secca come uno schiaffo in faccia. La terra era nera, chiusa in se stessa, le montagne erano scomparse, anche il Monviso non si vedeva più.
“Ecco, siamo arrivati. Questa è una di quelle aziende che sembrerebbero confermare la tua teoria. È rimasto solo un giovane uomo, gli altri sono tutti vecchi. Lui manda avanti la baracca da solo, non si sposa, non avrà figli ma resterà qui a lottare fino alla fine. Forse quando avrà la schiena rotta accetterà di farsi aiutare da qualche indiano, chissà. Secondo me dovresti cominciare a girare da qui, leggi, “L’Italia a mio avviso deve rimanere una nazione a economia mista con una forte agricoltura che è alla base di tutto”. Che te ne pare?” disse imboccando il sentiero che portava alla cascina.
“Fermati un attimo, Veronica, che faccio una panoramica da qui”, disse lui infilandosi il berretto di lana. “Credi che accetteranno di farsi riprendere?”
“Non lo so, puoi sempre provare a chiedere. Nuto Revelli ci ha messo anni a farsi raccontare queste storie, forse devi prima conquistarteli un po’”, rispose lei ridendo.
La macchina si fermò in mezzo all’aia, i cani cominciarono ad abbaiare come forsennati, tirando sulla catena come a volersi impiccare. Uscì una vecchia col bastone e il grembiule a fiori.
“Buongiorno signora, sono la veterinaria, si ricorda?”
La vecchia fece un cenno con il capo, spifferò qualcosa dalla fessura della bocca, dove le erano rimasti pochi sparuti denti. Indicò la stalla. Nell’aria c’era odore di paglia e di pane, gli anziani erano al forno e stavano tirando fuori le miche dorate che mettevano in un grande cesto di vimini. “Questo pane ti dura un’intera settimana” fece lei prendendo la valigetta, “vatti a fare un giro intanto, io devo parlare con Toni”.
Lo vide che sistemava la paglia nel recinto dei vitelli, dava loro pacche sulle testa come un padre che guarda compiaciuto i suoi figli. Restò qualche istante a guardarlo, con quel cappello sghembo, la camicia a quadri rossi, i pantaloni di tela blu, era forte, pareva che i movimenti non gli costassero alcuna fatica. Ogni volta che entrava in quella stalla, si chiedeva preoccupata quanto avrebbe potuto ancora durare. Il tempo si era fermato lì, su quei muri sporchi, in quell’odore forte e così familiare di bestie e di uomini. Vide la mucca con la pancia grossa e pensò che era prossima al parto. Due gatti correvano su e giù, giocando tra di loro. Quell’odore le sarebbe rimasto addosso fino a sera, sui vestiti, nel naso. Lui si girò e alzò il braccio in segno di saluto, “salve dottoressa”. Poggiò la forca e si avvicinò, porgendole il braccio, non le stringeva mai la mano nella stalla, “ho le mani sporche” diceva quasi con vergogna.
“Allora Toni, dobbiamo tagliare?” domandò.
“Questo me lo deve dire lei, dottoressa”. Si spostarono verso il fondo della stalla dove c’era la vacca gravida. Lei, con i guanti, infilò una mano dentro la vagina della mucca. “E’ ancora tutto chiuso qui. Speriamo che il vitello non stia soffrendo. Se non succede niente entro due giorni, facciamo il cesareo”.
“Come crede” disse Toni. C’era qualcosa nel suo sguardo che assomigliava alla rassegnazione.
“Devo prelevare dei campioni di sangue per la TBC, stai tranquillo, mi pare che qui se la passano bene le bestie”, disse lei come per incoraggiarlo.
“Non si può mai sapere” fece lui abbassando gli occhi, “giù a Santa Maria, da mio cognato, hanno trovato delle bestie infette. Vado a prenderle il tavolino”.
Tirò fuori da un angolo della stalla un’asse con due cavalletti, così che la dottoressa ci potesse appoggiare sopra la sua valigetta e lavorare comoda. Toni si era chiesto dalla prima volta che l’aveva vista perché una giovane donna dai modi così raffinati avesse deciso di passare la vita in quell’angolo abbandonato di mondo, a fare un lavoro da uomo. Però il suo mestiere lo faceva bene, sapeva trattare con le bestie, aveva gesti sicuri, professionali e amorevoli allo stesso tempo. Quando ebbe riempito le provette, la dottoressa si tolse i guanti.
“Mi pare che i vitelli stiano bene, anche il piccolo che non ciuccia”, disse. Si vedeva che Toni amava i suoi animali, lì dentro c’era una calma tutta particolare, come quando si entra in una classe di bambini che hanno una brava maestra. “I risultati tra una settimana, ma se hai bisogno di me per il parto, chiama mi raccomando, non fare al solito che vuoi riuscirci da solo”.
“Lei ascolta solo me” disse Toni, accarezzando la pancia di Asia, “a volte smia propi qu’an capisa. A l’e nen ma iuatri. As ferma a piè café? Maq pur as scandese nà minuta”.
“Volentieri. Ti devo presentare un amico che vorrebbe girare un documentario sulla vostra vita qui.” Toni la guardò come se avesse parlato in cinese.
“E a chi potrebbe mai interessare?” domandò stupito.
“A me” disse la dottoressa sorridendo, “andiamo che fa freddo.”
Una pioggia gelida e sottile cominciava a cadere dal cielo grigio. Entrarono nella grande cucina. I vecchi avevano riportato dentro il pane avvolto negli stracci che profumava tutta la stanza. Sul fuoco della vecchia cucina a gas borbottava una minestra. La donna anziana con il grembiule a fiori era seduta sul divano e guardava le immagini mute della televisione. Tutto intorno era silenzio. Era un mondo senza parole, quello, così si era conservato intatto. Ogni volta che incontrava Toni, la assaliva una strana nostalgia, come di qualcosa che non aveva vissuto, ma di cui sentiva la mancanza.
3.
È la notte che si nasce. Nel buio pesto. Un muggito lancinante che squarcia il silenzio. Ci siamo. In un attimo sono tutti giù a infilarsi gli zoccoli, Toni e i vecchi, l’acqua calda per lavarsi le mani. Attraversano la corte di corsa e non si accorgono del freddo che punge come un manto di spilli. La bestia è tesa, nervosa. Lui subito le parla mentre gli altri preparano la carrucola.
“Lo tiriamo fuori subito, da brava, se tu ci aiuti…non aver paura”.
“Stort, le propi stort. Se lu tiruma fora parej, lu masuma”.
“Toni và a ciamè la dutur˘ssa”.
Toni non vuole chiamare la dottoressa, vuole essere lui a tirare fuori il vitello. Asia non lo perdonerebbe. Vuole fare in fretta per non farla soffrire. Prima che la dottoressa arrivi, passa almeno un’ora, troppo tempo. Troppo dolore. Tutte le bestie sono agitate, c’è rumore, confusione. Paura. Le zampe, tira fuori le zampe, forza. Il sudore gli cola sugli occhi, vede suo padre che si accascia in un angolo, la madre che gli si butta addosso.
“Portelu fora a piè n’po’ d’aria” urla Toni mentre prepara la corda. Si sente dilaniato, un dolore al petto come una spada che lo taglia a metà, non può lasciare la bestia, non adesso che il piccolo sta uscendo e lei urla e anche sua madre urla mentre trascina fuori il corpo dell’uomo. Cola il sangue e il muco e per la prima volta Toni pensa che non ce la farà. Non ce la fa a reggere, è troppo anche per lui. Tira sulla corda ma non succede niente. Ora è solo. Pensa che vorrebbe avere la dottoressa accanto, solo così, per compagnia. Il suo sorriso bello, quel modo gentile di rassicurarlo sempre. Attacca la corda alla carrucola appesa al soffitto per tirare con più forza. Più forza. Ha tutti i muscoli tesi. Poi la mucca dà una spinta e il sacco esce tutto insieme, fa il rumore di un frutto maturo che cade. Il piccolo giace a terra, fermo, in mezzo a tutta quella massa rossa, dove è cresciuto, la placenta che l’ha nutrito. Toni scioglie la corda, “bugia, forsa” dice al vitello. La bestia non lo guarda nemmeno. Come se già sapesse. Toni prende del sale grosso e glielo mette sulle narici.
“No, l’è pa vré” urla Toni, “a l’e viu, propi viu, sagrinte nen”. Il piccolo ha come uno spasimo, con un colpo secco si mette in piedi ma subito dopo scivola giù, come se si trovasse su una lastra di ghiaccio liscia e sottile. Toni lo afferra e lo ritira su, lo abbraccia e non capisce se sono lacrime o è il sudore che continua a colargli sugli occhi, impedendogli di vedere.
“Forsa picinin, cu da la mama”, lo spinge, lo tiene mentre il vitello scalpita con movimenti disorganizzati, le gambe come stuzzicadenti che non reggono il peso del corpo. Il latte già scende. Asia è in piedi, si è alzata come una dea emersa dagli inferi. La mucca che le sta accanto si gira, si avvicina e con la lingua le accarezza la testa, come volesse dirle: – è tutto finito. Ce l’hai fatta, brava -.
“A l’è tut to” dice Toni, commosso da quel gesto così umano, o meglio così animale. Deve tenere il piccolo, altrimenti cade. Gli avvicina la testa alle mammelle, allora lui dà delle botte, non capisce cosa deve fare. “Forsa, ciucia”. Poi finalmente il vitello si attacca. La mucca piange. Non potrebbe giurarci ma gli sembra che pianga, ha gli occhi umidi, proprio come i suoi.
“Brava, brava, sos propi staita brava. Ura veni subit a pulidé. T’laj vist? L’uma faila sensa tajé”.
Fuori la pioggia ha cambiato consistenza, è nevischio, gocce pesanti e dense, un paio di gradi e nevica. Il sudore gli si ghiaccia sulla schiena. È uscito di corsa, senza giacca, con le mani imbrattate di sangue. La sirena blu dell’ambulanza compare alla fine del viottolo. Non fa rumore. Lui riesce appena ad entrare in casa, il padre è steso sul divano, bianco come fosse già cadavere. Nessuno dice una parola. Neanche lui, ha la gola strozzata. Mentre gli infermieri lo mettono sulla barella, il medico chiede qualche generalità. Risponde la madre, Toni non riesce a capire nemmeno le sue parole. Le immagini sono mute come quelle che guarda sua zia alla televisione. Vede sua madre buttarsi il cappotto sulle spalle e infilarsi nell’ambulanza, nella fretta ha dimenticato di togliersi gli zoccoli. Toni le corre incontro per darle le scarpe, non vuole che provi vergogna quando sarà arrivata all’ospedale. I suoi scompaiono nella notte insieme alla luce intermittente. Toni torna nella stalla. Prepara la paglia nuova per il piccolo, controlla che la vacca non abbia perduto troppo sangue, pulisce per terra, poi si siede accanto a lei e piange. Dal silenzio che regna tutto attorno, capisce che fuori sta nevicando.
4.
La luce torna in sala insieme ad uno scroscio di applausi. Lui sente le guance rosse per l’emozione. Incontra lo sguardo di Veronica e il suo sorriso aperto. Le stringe una mano, anche se si sente il palmo sudato. Adesso che ha vinto un premio, dovrà dire qualcosa. Proprio non se lo aspettava. Riguardando quelle immagini si è sentito triste. C’è qualcosa in quegli sguardi, in quei paesaggi, che rimanda alla fine. La storia che ha raccontato è una storia che finisce, sepolta dalla neve e dall’indifferenza. In sala qualcuno ha mormorato durante la scena del macello. Stranamente ha fatto effetto anche a lui, come se rivederla fosse più duro che viverla. Mentre era lì era troppo preoccupato di girare, aveva solo occhi, non aveva cuore. È così che si sente quando gira, quello che ci mette dentro lo capisce solo dopo, quando le immagini si sono ricomposte. È una cosa crudele e ingiusta. Una cosa da avvoltoio. Vengono a stringergli la mano, lo invitano sul palco ma lui non sa cosa dire. Adesso vorrebbe tornare a casa e mettersi a letto. Stringere il corpo caldo di Veronica e scivolare in un sonno lungo un’intera settimana. Invece lei è lì che lo guarda e gli dice “dai, Vittorio, accidenti che ti prende?”. Lui allora sale sul palco, gli tremano le gambe. La prima cosa che fa è ringraziare i produttori che hanno finanziato il documentario, così prende tempo, poi ringrazia Veronica, senza la quale tutto quello non sarebbe successo, poi non ha altro da aggiungere. Si scusa, gli manca la voce. “Quello che volevo dire…insomma…l’ho detto con le immagini. È stato un lavoro bello e difficile, vincere la diffidenza delle persone, sedermi con loro a tavola, chiacchierare di cose quotidiane…in piemontese”, lentamente la voce si scioglie, come un calore che sale da sotto, forse il ricordo di quegli attimi preziosi, “io volevo mostrare un mondo che finisce ma mentre ero lì, mi sono accorto che questo non aveva senso, come può finire una storia nella quale affondiamo tutti le nostre radici?”.
Veronica lo guarda ed è fiera di lui, lui continua, “il loro modo di vivere è così vero che è il nostro ad apparire improvvisamente assurdo. La mattina mi svegliavo con il desiderio di andare in cascina, passare il tempo con loro, stare all’aperto con il freddo, la pioggia, la neve, al caldo nella stalla o davanti alla stufa. Ho amato quel silenzio fatto di poche, essenziali parole, molti gesti pieni di sapienza, antiche conoscenze tramandate da generazioni. Ho capito che la bellezza che mi circondava era frutto del vero. Mi sono sentito accolto e mi sono lasciato andare, girare era quasi un disturbo, mentre ero lì, avrei voluto mettermi a lavorare, curare le bestie, l’orto e i campi, avrei voluto cucinare, fare fatica. Aiutarli. Perché sono rimasti soli. Li abbiamo abbandonati”.
Prende fiato, in sala c’è un grande silenzio attento. “Oggi avrei voluto che fossero qui con noi, tutti coloro che hanno accettato di raccontarmi qualcosa della loro vita, ma non se la sono sentita, mi hanno detto che loro al cinema non c’erano mai stati e che si sarebbero vergognati di vedersi così, su uno schermo, davanti a tutti. Questo premio è per loro.”
Applausi.
Chiara Mezzalama

Chiara Mezzalama è nata a Roma il 28 settembre 1972. Vive a Parigi. Figlia di un diplomatico, ha passato la sua infanzia all’estero. Scrittrice, traduttrice e psicoterapeuta, ha pubblicato il suo primo romanzo, Avrò cura di te con le Edizioni E/O nel 2009. Scrive per la rivista della Società Italiana delle Letterate Leggendaria e per il blog di lettura Tempoxme, collabora con la rivista Left. Ha scritto un diario sugli attentati terroristici a Parigi Voglio essere Charlie: diario minimo di una scrittrice italiana a Parigi per Edizioni Estemporanee. Il giardino persiano è il suo secondo romanzo.