di Eleonora Mancini Durante Mangoni
Se esiste una scrittura epica in chiave moderna, mezzo espressivo di archetipi, miti e storie di una collettività, quella di Jumpa Lahiri lo è senz’altro. La sua è la voce della comunità indiana negli Stati Uniti e come tale viene riconosciuta sin dalla prima raccolta di racconti, “L’interprete dei malanni”, che nel 2000 vince il Premio Pulitzer.
Ho letto tutto di lei e desideravo molto conoscerla: l’ho incontrata qualche tempo fa a casa di un amico, docente di glottologia, che nutriva nei suoi confronti un duplice interesse, artistico e professionale. Mi aveva profondamente colpito ed affascinato il fatto che Jhumpa Lahiri fosse venuta in Italia per imparare l’Italiano e che fosse stata addirittura capace di scrivere in una lingua che non le appartiene. Mi interessava avere conforto ad una smania che mi assale spesso e che forse non è solo mia, causata da una seconda lingua che conosco bene ed è parte importante del mio vissuto, una lingua “altra” che non ho occasione di parlare di sovente, ma che proprio per questo mi punge con una nostalgia dolorosa, localizzata nelle corde vocali e sotto il palato: la smania – mi viene da dire – che forse hanno i pianisti nelle dita quando sono lontani dalla tastiera…
“Una parte di vita vissuta in un sistema linguistico diverso, sposta il baricentro: è un fatto fisico…”. Jhumpa ha uno sguardo complice e sorride: è una donna bellissima, alta, esile, aristocratica, con i colori caldi ed esotici dell’India. Inizia a parlarmi ed il suo Italiano è ottimo, senza accenti, poche inflessioni, suoni rotondi su cui galleggio, quasi fosse una sinfonia nota nell’interpretazione originale di un direttore d’orchestra sorprendente…
Jhumpa Lahiri nasce da una famiglia bengalese e cresce negli Stati Uniti, immersa nelle mille spinte centrifughe e centripete che l’integrazione comporta. Le due lingue rappresentano le sue due facce: il Bengalese, lingua madre, familiare ed affettiva, lingua della famiglia e delle relazioni con la comunità indiana, e poi l’Inglese, lingua matrigna, della scuola, della socializzazione con i coetanei, ma anche della sua scrittura e creatività artistica. Due lingue che viaggiano su binari paralleli, spesso “l’una insofferente dell’altra”, con “nulla in comune – scrive Jhumpa – tranne me, per cui mi sentivo una contraddizione in termini anch’io”. Due linee contrapposte, finché non compare un terzo idioma, d’elezione, amato e corteggiato: l’Italiano, che rende la contrapposizione una forma, una triangolazione, un rapporto rigenerante.
Jhumpa Lahiri visita l’Italia quando è ancora studentessa: nel 1994 a Firenze scopre di avere un rapporto “uditivo”, oltre che visivo ed emotivo, con l’Italia: “Mi rendo conto di un rumore che mi piace, delle conversazioni, delle frasi, delle parole che sento ovunque vada. Come se tutta la città fosse un teatro che ospita un pubblico leggermente inquieto, che chiacchiera prima dell’inizio di uno spettacolo”. E’ un colpo di fulmine. Il ritorno negli USA le conferma di non poter vivere senza l’Italiano e Jhumpa inizia il lungo viaggio che la porterà ad apprendere la nostra lingua, a farne l’altra espressione della sua scrittura e di un libro bello e profondo: “In altre parole”, ed. Guanda 2015.
Apprendere una lingua è un’avventura avvincente ma dura, gratificante ma totalizzante ed investe tutto il vissuto dell’Autrice. All’urgenza di apprenderla (“So che sarei insoddisfatta, incompleta se non la imparassi…esiste uno spazio dentro di me per farla stare comoda”), segue presto la consapevolezza che la conoscenza non progredisce esiliata dalla pratica. Jhumpa fa una scelta definitiva: si trasferisce con la sua famiglia a Roma, dove affronta lo studio con umiltà e pazienza, ma anche con grande caparbietà. Nella prima fase, nell’incertezza espressiva dei primi tempi, Jhumpa Lahiri vive un esilio linguistico che conosce bene, che le fa riscoprire il suo vissuto di madrelingua bengalese e di straniera rispetto all’Inglese. Il “senso di straniamento continuo” dell’Italiano è quello che ha provato per tutta la vita, sospesa in una terra ed in un contesto linguistico diverso, che pure hanno finito per appartenerle.
E proprio di questo stato di “straniamento” si nutre la poesia del suo racconto e con essa contagia noi, lettori linguisticamente competenti. Jhumpa rimane stregata dai suoni: claustrale, sciagura, spigliatezza, inviperito, stralunato. Si fa “raccoglitrice di parole”: “Ogni giorno entro in un bosco con un cestino in mano. Trovo le parole tutt’attorno: sugli alberi, nei cespugli, per terra… sento un legame con ogni parola che raccolgo. Provo affetto, insieme a un senso di responsabilità. Quando non riesco a ricordarle, temo di averle abbandonate”.
Con un lavoro di grande disciplina, inizia a parlare, ma soprattutto desidera scrivere. Ed è dura : “come se, poco attrezzata, scalassi una montagna”, spiazzante: “Mi rendo conto di uno stato di privazione. Eppure, al contempo, mi sento libera, leggera” Dopo il diario arrivano le prime prose, brevi, imperfette e con esse sperimenta l’umiltà di accettare correzioni, di lavorare di cesello “come se non avessi mai scritto nulla nella mia vita…in un’altra dimensione dove sono senza riferimenti, senza corrazza”.
Jhumpa Lahiri rinuncia alla sua autorevolezza di scrittrice riconosciuta, “forte” nella lingua che le è propria, per esprimersi in una lingua che mette in crisi l’intero sistema: “Cosa vuol dire rinunciare a un palazzo per abitare quasi per strada, sotto un riparo così fragile?”.
Ma dallo sforzo di contenere il fiume in piena dell’ispirazione in parole scarne e limitate, scaturisce una consapevolezza interiore: ogni sua esperienza da sempre passa per le parole, scrivere significa conoscere, essere, per Jhumpa Lahiri: “appartengo soltanto alle mie parole”. Anche la conoscenza dell’Italiano non può evitare di passare per la scrittura.
Necessario (ed esilarante per il lettore!) attraversare le asperità della nostra grammatica, le bizzarrie delle sue categorie: “ALLA parete” ma “PER terra”, “DAL calzolaio” ma “IN edicola”, “c’è vento” ma “c’è IL sole”, “uno stato D’animo” ma “una busta DELLA spesa”). E poi: “limite” e “limitazione”, “funzione” e “funzionamento”, “modifica” e “modificazione” e le difficoltà dei verbi, la loro sensibilità sottile che diventa consapevolezza esistenziale “Mi identifico con l’imperfetto, perché un senso d’imperfezione ha segnato la mia vita. Ho provato da sempre a correggermi…”.
Jhumpa Lahiri non prescinde nemmeno dallo studio attento e partecipe della letteratura italiana moderna e contemporanea, dei classici. Ed è proprio in un testo latino amato da sempre, le Metamorfosi di Ovidio, il mito della trasformazione di Dafne, che Jhumpa trova, come scolpito, il senso di questo suo bizzarro destino, di scrittrice che fugge da sé stessa per trovarsi inchiodata nel legno, ma salva, libera : “l’Italiano mi copre come una specie di corteccia. Resto dentro rinnovata, incastrata, sollevata, scomoda”.
Come Dafne, Jhumpa si scopre in fuga da sempre, una fuga disperata dal confronto con l’Inglese e la sua cultura, che ha vissuto come una spaccatura interiore, come un’esigenza estenuante di interpretazione. All’Inglese, lo riconosce, deve il suo successo, ma anche il successo diventa limite. L’Italiano la riporta all’essenzialità della scrittura, le dà diritto di smantellarsi e ricostruirsi, di fallire ed essere imperfetta. Le dà il diritto di cambiare, lei figlia di genitori che hanno vissuto una vita altrove senza mai adattarsi ad usi e costumi diversi da quelli dell’India, senza mai affidarsi al cambiamento.
Un cambiamento, il suo, che spaventa e che viene vissuto come un tradimento: la dissuadono i suoi lettori americani, i suoi editori. Inutile: “I momenti di transizione, in cui qualcosa si tramuta, costituiscono la spina dorsale di tutti noi…Danno l’ossatura alla nostra esistenza. Tutto il resto è oblio” e ciò che cerchiamo dell’arte è qualcosa capace “di svegliarci, di colpirci fino in fondo, di cambiarci”.
Le scrive Domenico Starnone e ripete, per me, Jhumpa Lahiri: “Una lingua nuova è quasi una vita nuova, grammatica e sintassi ti rifondono, scivoli dentro un’altra logica e un altro sentimento”..
Dentro un’arte nuova, “In altre parole”.
Eleonora Mancini Durante Mangoni

Una laurea in Lingue e Letterature Straniere e una specializzazione all’Università Statale di Mosca, poi vari anni di lavoro nell’ambito della comunicazione e promozione del “made in Italy” all’estero. Ha collaborato con scrittori e giornalisti in progetti editoriali, conducendo lo studio dei materiali di ricerca in lingua russa. E’ membro del Consiglio dell’ACDMAE, si occupa del Notiziario, di EUFASA e del sito www.POSTEDTO.com
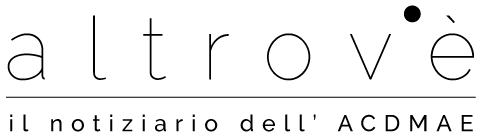

Leggendo questo articolo di Eleonora ho scoperto una penna fluida, esatta, dettata da un elegante lucidità di pensiero. Credo che la lingua sia questione fondamentale, la lingua siamo noi.