di Stefania Bertoni Sperduti
Guardo i miei bagagli, poco ingombranti, preparati velocemente e lasciati con noncuranza all’angolo della stanza. Dentro poche cose buttate alla rinfusa un po’ come i ricordi che sto faticosamente mettendo insieme. Dopo solo due mesi (che ora pesano come due anni) lascio l’Etiopia: una guerra, dopo un anno di conflitto latente in Corno d’Africa, è giunta a sorpresa alle porte di Addis Abeba dove ancora lavora mio marito.
Quando sono arrivata nella Capitale, a settembre, mai avrei pensato di dover toccare con mano la più tragica emergenza umanitaria dei nostri giorni. Sono arrivata qui piena di entusiasmo e curiosità con la convinzione che – appena trovato un momento – avrei scritto per Altrov’è un pezzo di colore su una città che ha un complesso e affascinante passato legato indissolubilmente alla storia del nostro Paese. Mi ritrovo invece a parlare di un terribile conflitto in corso, di cui nessuno riesce a prevedere, purtroppo, il finale.
Sapevamo bene che a nord, nella regione del Tigrai, infuriava la guerra civile dal novembre del 2020. Quelle sommosse sembravano lontane da Addis Abeba, dove si respirava un’aria tranquilla: non già perché la città non fosse caotica e frenetica – un po’ come tutte le megalopoli africane – ma perché non si percepiva alcun allarme imminente. Tra i sei milioni di abitanti che affollavano le strade della Capitale non era difficile scorgere i segni della miserie e delle privazioni. Molti di questi erano affluiti da zone di guerra: dal nord del Paese, ma anche dai Paesi confinanti e dallo Yemen. Ma su tutto quel magma confuso si allungava, quasi a tranquillizzarci, l’ombra del gigante asiatico che da anni oramai non smette d’investire in questo Paese.
Sono cinesi, infatti, i maggiori investitori in Etiopia: hanno abbattuto vecchie costruzioni storiche, anche quelle progettate negli anni ’30 da nostri architetti, per costruire imponenti grattacieli, uffici e palazzi ultra lussuosi per stranieri…Come se Addis Abeba si stesse preparando a diventare una destinazione “business” di richiamo internazionale. Nessun piano regolatore ha mai provato a governare i nuovi cantieri e, quindi, le infrastrutture restano carenti, le strade inadatte a contenere il flusso enorme di auto e Tir che arrivano da Gibuti e dalle zone rurali del Paese.
L’elettricità peraltro subisce continue interruzioni, anche se l’Etiopia vanta un’immensa riserva d’acqua grazie alla nuova diga di GERD, acronimo di Grand Ethiopian Renaissance Dam, la cosiddetta “diga del Millennio”, la più grande centrale idroelettrica africana. Si iniziò a costruirla nel 2011 e, in teoria, avrebbe dovuto assicurare approvvigionamenti energetici già quest’anno.
Impensabile poter utilizzare Internet con regolarità o velocemente. E anche il servizio sanitario, neanche a dirlo, è pressoché inesistente. Ciò nonostante abbiamo condotto normalmente la nostra vita al quotidiano: facendo i conti col traffico, con i disservizi e anche – di tanto in tanto – con i pick up improvvisati e carichi di militari non sempre dallo sguardo rassicurante.
Alla fine di ottobre, dall’oggi al domani, è arrivato il drastico cambiamento: il Primo Ministro Abiy Ahmed, eletto nel 2018 e insignito con il Nobel per la Pace già nel 2019 (per aver firmato la pace con l’Eritrea dopo anni di sanguinoso conflitto) aveva dichiarato lo stato di emergenza. Cosa ancor più allarmante, la sua dichiarazione seguiva la sconfitta dell’esercito regolare da parte dei ribelli del nord che erano già arrivati a soli 400 chilometri dalla Capitale.
Eravamo in un paese in guerra e ce ne siamo accorti, improvvisamente, in quel momento. Sui social network, intanto, il Presidente invitava i cittadini a difendere la città con le proprie “armi” e a denunciare alle autorità il possesso di fucili o altri mezzi di difesa. Non avevamo neppure capito che la Capitale in realtà era armata fino ai denti: armi comprate negli anni, con estrema facilità, anche da persone qualunque, ai mercati neri che prosperano al confine della Somalia o del Sudan.
Ci siamo spaventati e abbiamo cominciato a consultarci febbrilmente con amici della comunità internazionale. In poche settimane, in un contesto non facile come quello di Addis Abeba, avevo avuto modo di conoscere facilmente un gruppetto abbastanza nutrito di consorti, molte delle quali nordeuropee, carine e disponibili. La domanda che si rincorreva in quelle ore era sempre la stessa: sono “fake news”? Cosa sta succedendo veramente?
Il culmine della tensione arrivò però una sera, quando ci avvisarono che erano iniziate le perquisizioni dei compound del nostro quartiere. Quella sera per fortuna nulla accadde ma la paura fu tanta. E a quella si stavano aggiungendo altre difficoltà altrettanto reali: i prezzi dei beni di prima necessità, sempre più difficili da reperire, stavano letteralmente esplodendo così come i prezzi della benzina e questo rendeva ancor più precaria la vita dei locali. Per noi era sempre più rischioso anche solo tentare di uscire di casa.
Sarebbe troppo complesso qui tentare di comprendere le ragioni più profonde di una guerra iniziata dai Tigrini – che hanno governato l’Etiopia per una trentina d’anni – sulla scia delle politiche adottate dal Presidente Abyi per cancellare sistematicamente i loro diritti. Le trattative fra governo e TPL, il Fronte Popolare di Liberazione del Tigrè, continuano serrate ma nessuna ha prodotto risultati concreti e neppure un cessate il fuoco.
Secondo le NU, le misure adottate finora dal governo centrale insieme alla carestia e alle frequenti invasioni di cavallette, hanno ridotto circa 7 milioni di Tigrini, di cui 400mila bambini, alla fame. La guerra poi, sta bloccando i convogli dell’Unicef e l’arrivo degli aiuti umanitari rendendo la situazione a nord sempre più insostenibile. E mentre i ribelli si alleano con altri gruppi armati per conquistare le città, donne e bambini cercano disperatamente rifugio in Sudan, perché il Kenya ha chiuso i confini. L’esercito regolare, invece, nonostante le dichiarazioni presidenziali, continua a perpetrare violenze di ogni genere contro i civili: stupri, omicidi, rastrellamenti e “sparizioni” sono all’ordine del giorno.
Molti stranieri hanno dovuto lasciare il Paese, anche se ancora non si parla di un’evacuazione massiccia degli occidentali. Ma chi come me ha dovuto lasciare velocemente casa non può restare insensibile a tutto questo. Continuiamo a seguire i fatti con apprensione, cercando di farci largo tra voci poco attendibili e rischi reali che incombono sui tanti funzionari, italiani e non, che stanno tuttora prestando servizio nel Paese. Con il pensiero fisso per il Corno d’Africa che non riesce a trovar pace e stabilità, dopo che anche la grande speranza di Abiy Ahmed – salutato come l’innovatore, l’uomo di pace – si è tradotta nell’ennesima e incomprensibile delusione.
Stefania Bertoni Sperduti

Nata e cresciuta a Roma, ha studiato per quattro anni in una scuola di formazione psicoanalitica prima di sposarsi e trasferirsi in varie sedi con il marito e le due figlie. Appassionata di storia dell’arte e sempre curiosa di visitare nuovi musei, ha lavorato per tre anni come volontaria nella Delegazione FAI di Roma. Ha lasciato quest’anno il Direttivo ACDMAE per seguire il marito, Ambasciatore italiano presso l’Unione Africana.
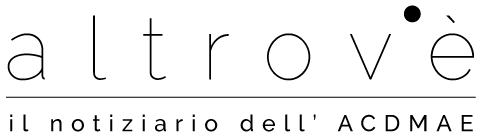





Che bell’articolo Stefy,emozionante viaggiare con te !