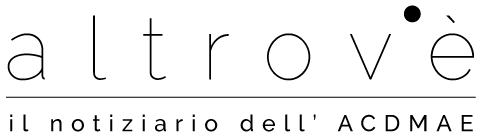di Francesca Andreini Galanti
Era accaduto una mattina, una di quelle in cui Anoush mi trafiggeva di aghi per curarmi un dolore alla spalla. Mi lasciava sul lettino, dopo, ad assopirmi, mentre il dolore si diluiva nella luce del sole, nel giallo della stanza e il profumo dell’incenso.
Anoush mi raccontava della sua vita a Damasco, che lei adorava. Del suo lavoro, che le dava tante soddisfazioni. Aveva uno studio nella piazza al centro della zona degli stranieri. Malki, con le case nello stile del mandato francese: piccole, ordinate e decorate di stucco bianco intorno alle finestre. Vialetti alberati, piazze e piccoli giardini ben tenuti. Il quartiere dei locali occidentali, degli uffici e delle ambasciate. Quella americana era lì a pochi passi.
Anoush mi parlava di come aveva dovuto lasciare l’Armenia per vivere senza documenti in Siria, la sua nuova patria. Poi mi chiedeva di me, dell’Italia, della mia vita lì a Damasco. Mi chiedeva di commentare gli eventi. “Hai visto cosa hanno fatto ai nostri fratelli iracheni? Quanti bambini sono morti! Che male avevano fatto?”
Avrei voluto dirle che avevo tremato vedendo le bombe cadere su Baghdad e sgretolare palazzi, riserve idriche, scuole e ospedali. Vedendo migliaia di iracheni abbandonare le loro case. Pagare per la colpa del loro presidente. Ma era poi una vera colpa? Le armi di distruzione di massa di Saddam Hussein… Tutti lì a Damasco lo sospettavano, che fossero una scusa per entrare in armi nel paese vicino. Per spodestare il regime. E anch’io, come tutti, mi chiedevo chi lo avrebbe sostituito. Chi avrebbe aiutato Assad, in Siria, contro l’islam radicale che avanzava…
“Non ti sembra terribile, Francesca?”
Sospiravo, tacevo. Tempo prima avevo parlato ad Anoush di una cosa che stavo scrivendo sulla Siria e pochi giorni dopo i servizi segreti erano entrati ben due volte in casa mia, frugando fra i miei file.
Forse solo una coincidenza. O forse la sua posizione richiedeva questo pedaggio, di collaborare con il regime. Da quel momento mi limitavo a tacere, mentre lei inveiva contro gli alleati Inglesi ed Americani, che facevano scempio dell’Iraq senza motivo, ferendo così anche i fratelli siriani. Uniti dalla stessa cultura, la stessa natura, lo stesso tipo di regime al potere.
E lo stesso popolo pacifico. Così mi pareva, da quando ero arrivata in quella Siria polverosa, lenta e paciocca. Anni di siccità avvolgevano di cielo azzurro e di luce abbacinante un paese immobile. Niente acqua dal cielo, nessun cambiamento sulla terra, da almeno due anni. Un paese polveroso e lento, ossessionato dal cibo e nient’altro. Con gli uomini dal ventre prominente nei negozi, a far la spesa, chiacchierando fra loro. E le donne, sotto le vesti ampie, a casa, a cucinare per ore. Mentre i muezzin cullavano le giornate di canti.
Pericolosa? No, mai. Rispondevo a chi si stupiva della mia fiducia e del mio affetto. La Siria che conoscevo era sicura, e non mi lasciavo disturbare dai segnali di pericolo. Come il nome stesso del luogo in cui vivevo: Dimashq. Credevo di vederlo scritto sui cartelli per strada, che erano strettamente in arabo per confondere il nemico in caso d’invasione. Ma i cartelli non indicavano Damasco. L’ho capito dopo qualche mese, quando ho iniziato a parlare e leggere l’arabo; il nome con cui i Siriani indicavano la loro capitale era Es-Sham, l’Oriente.
E questo fatto mi aveva turbato: “Non è che vedi solo quello che vuoi vedere?” mi aveva suggerito. Ma i dubbi li avevo presto ignorati, perché intorno a me c’erano mamme che si gettavano sulla mia piccola, la prendevano in braccio per baciarla e mi benedicevano per la grazia che mi era stata concessa; Dio mi guardava con benevolenza!
C’erano i beduini, nel deserto, che ci ospitavano nelle tende rattoppate, ci offrivano tè e biscotti, serviti da giovani mogli emozionate. Orgogliosi, ci mostravano le capre e i figli. Rattristati, respingevano i soldi che cercavamo di dare loro, dopo la nostra visita. “Siete stati nostri ospiti, vi abbiamo aperto la nostra casa con il cuore, perché ci offendete?”
Erano così, i siriani che conoscevo: generosi, curiosi e sorridenti. E il regime che ci faceva seguire per strada, che ci raggiungeva con telefonate quotidiane a casa: “Guardate che vi osserviamo, sappiamo tutti i vostri movimenti”, ci voleva dire. Ma nella cornetta non c’era una voce a esprimere il concetto. C’era una musica araba di sottofondo, in chissà quale stanza dove un agente dei servizi segreti si stava pur annoiando, a seguire le nostre noiose giornate, e aveva la radio accesa mentre faceva la chiamata di turno. Pacioso anche lui, in un certo modo. Innocuo, anche se irritante, come il ronzio di una mosca.
Per questo mi lasciavo andare alla voce di Anoush, e alle sue rimostranze, finché lei non smetteva di parlare e io mi addormentavo.
Dormivo anche quella mattina di dicembre, quando mi svegliarono di soprassalto le grida, i vetri spaccati, l’odore del fumo. Ho afferrato gli aghi e li ho strappati dal corpo, mentre Anoush mi fissava, immobile. Le mani mi si impigliavano nei vestiti, che cercavo di indossare in fretta.
Siamo uscite dalla stanza sul piccolo cortile, che si affacciava direttamente alla piazza, e abbiamo sbirciato dal portoncino socchiuso. Una massa di uomini copriva ogni centimetro, gridando contro gli Stati Uniti e il Regno Unito, agitando pugni, armi e cartelli.
“Che succede, Anoush?!”
“Non ne ho idea…”
“Qui siamo intrappolate! E se entrano…”
Io, bionda, venivo scambiata sempre per un’americana. “Amerkiie?” mi chiedevano, e io spiegavo ”La, italiie”; subito i sorrisi diventavano grandi, le braccia facevano il gesto di abbracciare, senza mai permettersi di farlo.
Ora, sbirciando in piazza, scoprivo espressioni mai viste prima. Contenevano odio, e uno sguardo appannato che non vedeva quello che aveva davanti, ma un nemico lontano, mostruoso, oscuro. Un nemico incarnato da persone come me.
Ho chiamato mio marito dal telefono dello studio. Stava bene, dove abitavamo noi non c’era sentore di nulla. “Accendi la televisione!”. Ma alla televisione davano i soliti programmi didattici, o i notiziari che mostravano il presidente Assad che inaugurava qualcosa. Stessa cosa alla radio. Di quello che accadeva intorno a me non diceva niente nessuno. Internet era oscurata. “Sta succedendo qualcosa di grave… Stanno sfondando porte e vetri, penso che entreranno anche qui! Non può venire qualcuno ad aiutarmi?”
“Non… io non… ”
Cittadina italiana, moglie di un funzionario dello Stato in servizio all’estero, mi ero sempre pensata protetta da qualcosa che adesso, nell’esitazione di mio marito, si palesava in tutta la sua inconsistenza.
“Vengo io, dammi solo il tempo per lasciare la bambina a qualcuno!”
Ma la bambina, appunto, aveva bisogno di qualcuno con cui restare, se le cose fossero andate male. E quindi gli ho detto di non muoversi, che in qualche modo sarei tornata.
“Meglio uscire adesso, che sono presi da altro. Se aspettiamo che si calmino è più facile che ci notino”, ha detto Anoush.
Abbiamo chiuso il portone dietro di noi e siamo entrate nella piazza.
La folla era lì, dappertutto; si muoveva in rivoli distinti, compatti. Se mi avessero notato, ne bastava uno che puntandomi il dito addosso avesse detto ”Amerkiie!” e un altro mi avrebbe tirato una pietra sulla faccia. O un pugno nel petto. Dovevamo diventare invisibili e guardandoci negli occhi, senza dover parlare io e Anoush ci siamo dette questo: “Facciamoci folla”.
Abbiamo camminato con gli occhi bassi nella massa, fra le spinte; unica bionda, unica con i capelli corti. Siamo restate fra i rivoli umani che urlavano contro di noi, ma noi eravamo loro, e quindi non si accorgevano di averci accanto.
Finché siamo rimaste folla non è successo niente; camminavamo fra gli altri, lasciandoci portare, ma anche procedendo lentamente verso la mia auto, poche strade più giù. L’abbiamo vista di lontano e ci siamo sentite salve. Siamo entrate, abbiamo chiuso gli sportelli e sospirato. L’incanto si è rotto. Eravamo di nuovo estranee alla folla, eravamo di nuovo “loro”. Ci hanno circondato e battevano sul tetto, battevano sui finestrini. Gridavano chissà cosa contro le nostre facce abbassate.
Ho pensato che se avessero cercato di rompere i vetri io sarei partita di scatto. Avrei messo tutta la forza del motore fra me e i loro corpi. Ho pigiato l’acceleratore ma piano, per contrastare la mia visione di morte. Ho sfiorato il pedale e la macchina, gentilmente, si è mossa. Non volevo fare del male a nessuno.. volevo solo tornare a casa.
Si sono accorti del movimento lento. Si sono scostati, ci hanno lasciate passare. E si sono diretti, di corsa, verso chissà quale obbiettivo.
Ho guidato a passo d’uomo fino a qualche strada più giù, dove di colpo il tumulto era finito. Non più folla inferocita, fumo o urla. C’erano le solite casette mal rifinite, i bambini a giocare per strada e i venditori, sonnolenti, seduti accanto alle botteghe.
A passo d’uomo ho superato i camion e le ultime case del quartiere, mi sono spinta nella periferia dove abitava la mia amica, lasciandola vicino casa. Io sono andata alla mia. E ho trovato mio marito, in mezzo di strada, che mi aspettava.
Nei giorni successivi abbiamo scoperto che il 20 dicembre Damasco era insorta per sdegno contro il bombardamento di Baghdad. E per mostrare all’Occidente che non avrebbe gradito lo stesso trattamento. La manifestazione, promossa dal regime, era degenerata. Centinaia di persone, gridando slogan contro l’Occidente, avevano distrutto tutto quello che avevano trovato di “straniero”.
Erano entrati nel British Council e avevano chiuso bambini e insegnanti in alcune stanze. Poi avevano ridotto in pezzi tutto quello che stava nell’edificio. Si erano sfogati anche sulle macchine degli stranieri in sosta, e quindi erano penetrati nella residenza dell’ambasciatore americano, sotto gli occhi immobili di quattro Marines di guardia che avevano ricevuto l’ordine di non opporre resistenza. Quella massa inferocita e frustrata – l’ambasciatore e la sua famiglia erano già stati messi in salvo su un elicottero militare – era allora tornata sui suoi passi, dando fuoco a ciò che poteva bruciare.
Lo avevamo scoperto dai giornali stranieri. E dai racconti dei testimoni: le madri dei bambini sotto shock, il responsabile della croce rossa, i diplomatici americani…
Da quel ricordo nasce un brivido che diventa anche oggi reale. Risale la schiena e inonda la testa. Sospiro, e trovo la forza di poggiare le dita al lavoro, sulla tastiera.
Francesca Andreini Galanti

Dopo la laurea in Lingue e Letterature straniere moderne, ha lavorato nella redazione di programmi TV, a Mediaset e a Telemontecarlo. Ha vissuto in Siria, in Senegal e a Washington DC. Ha pubblicato vari racconti e due romanzi: “Nessuno ti può costringere”, QuiEdit, 2009 e “Primi anni a WDC”, Edizioni del Gattaccio, 2015. Ha scritto per il teatro e il cinema e da oltre dieci anni collabora con la rivista letteraria online “Zibaldoni e altre meraviglie”. Fra il 2012 e il 2014 ha coordinato a Washington il Club ParoLab, per promuovere la letteratura italiana contemporanea. A Roma, prima di ripartire per Bangkok dove vive tuttora, ha tenuto vari laboratori di narrativa e curato gli eventi del circolo letterario Bel-Ami.