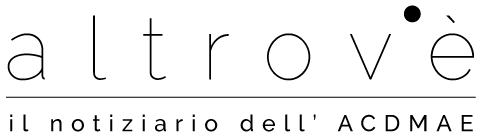di Marina De Antonellis Smimmo
La famosa frase “…Ma non ho nulla da mettere!”, che da sempre costituisce l’alibi perfetto per dar sfogo alle nostre pulsioni più sfrenate da shopping compulsivo, dovrebbe quantomeno, una volta arrivate sul luogo del delitto, essere seguita da alcune considerazioni che possano renderci consumatori più attenti e consapevoli.
L’industria della moda – è bene ricordarlo – è una delle più inquinanti. L’intero settore contribuisce per il 10% delle emissioni totali a livello globale, più di quanto facciano il settore dell’aviazione e del trasporto marittimo messi insieme. Le inefficienze riguardano tanto la produzione quanto il suo consumo. Sul primo fronte, quello della produzione, sicuramente si tratta di un settore con un modello di business che è stato caratterizzato da un’economia a sviluppo lineare, dominata cioè dal “vecchio” paradigma produzione, consumo e scarto. Ciò significa che le materie prime sono estratte o raccolte, poi trasformate in prodotti che vengono acquistati, utilizzati e gettati come rifiuti perché in questo modello economico – oggi, per fortuna, sempre più messo in discussione – il valore viene creato producendo e vendendo quanti più prodotti possibile.
Le criticità a livello ambientale di simili modelli riguardano gli elevati livelli di CO2 immessi nel pianeta ma anche la grande quantità di sostanze inquinanti riversate nelle acque reflue e nei corsi d’acqua, per non parlare del rilascio di microfibre plastiche che dai fiumi arrivano agli oceani. Si calcola che il comparto tessile globale, a seguito del lavaggio dei vestiti, arrivi a produrre oltre 500mila tonnellate di microfibre, l’equivalente di 50 miliardi di bottiglie di plastica, che finiscono regolarmente negli oceani. Tra le microfibre, il poliestere, un materiale presente nel 60% dei capi, fa la parte del leone: da solo rilascia nell’atmosfera il doppio o il triplo della quantità di emissioni di CO2 necessarie per produrre il cotone, con l’aggravante di essere anche un materiale che non si decompone nei mari.
Sul fronte del consumo, poi, le problematiche scaturiscono dal fatto che questo sistema spinge verso modelli comportamentali fortemente consumistici e pratiche di acquisto sempre meno sostenibili: comprare sempre di più per indossare sempre di meno!
Ben l’85% degli abiti in circolazione, secondo studi recenti, finisce annualmente in discarica anche perché l’indumento è utilizzato mediamente il 36% in meno rispetto a 15 anni fa. Basterebbe indossarlo il doppio di volte per abbattere le emissioni di gas serra del 44%! I diktat dell’industria del Fast Fashion – con un numero di collezioni e di capi per collezione impressionante, venduti a prezzi stracciati – rendono tuttavia l’operazione di allungare la vita del vestito molto difficile.
E allora che fare per rendere il Sistema Moda più sostenibile?
Il primo passo (e molte aziende del comparto, per fortuna, l’hanno già compiuto) è introdurre un modello di economia circolare – basato sul paradigma riduzione, riutilizzo e riciclo – al posto del modello lineare. A livello di catena produttiva questo significa introdurre il concetto di circolarità delle risorse: eliminare l’utilizzo di sostanze chimiche nocive, impiegare materie prime naturali, che possano essere facilmente riutilizzate, ma anche produrre con fonti energetiche pulite e limitare la lunghezza delle catene di valore, per esempio privilegiando fornitori locali.
Sono numerosi gli esempi di chi, in Italia e nel mondo, ha deciso di scommettere su un nuovo approccio comprendendo che un modello economico circolare può offrire molteplici opportunità di crescita e d’innovazione. Pionieri in questo, grandi brand come Patagonia ma anche celeberrime firme della moda nazionale come Brunello Cucinelli, che con il suo “capitalismo umanistico” ha fatto scuola oppure Giorgio Armani, tra i primissimi a scegliere di ridurre il numero di collezioni, facendo da apri-pista ad altre maison di richiamo come Gucci. E poi abbiamo un numero crescente di startup e di piccole aziende che sono riuscite a fare della moda sostenibile il loro vessillo traendone un indubbio vantaggio competitivo. In questi casi, “essere sostenibili” significa preservare filiere a rischio di estinzione (si pensi al progetto WuuLs per la lana abruzzese), ridare vita a materiali di scarto per creare scarpe di lusso (Prota Fiori), rigenerare tessuti e lane pregiate (Refabrics) o anche sostituire le tinture chimiche con quelle derivate da piante e fiori (Eleonora Riccio).
E’ difficile tenere conto di tutte le innovazioni e dei tanti progetti improntati all’ecosostenibilità che si sono fatti strada in questo comparto. Una realtà promettente che non deve tuttavia trarre in inganno: cambiare modello di produzione è un buon passo ma non è certo sufficiente. Occorre modificare anche le nostre abitudini di consumo adottando un modello “slow”, che preferisce la qualità del capo alla quantità. Vestiti che, per tessuti e taglio, possiamo utilizzare più a lungo, riporre nell’armadio per più stagioni, passare ai nostri figli o, addirittura, trasformare. Capi che ci inducono a riflettere e a sperimentare nuovi modelli di business, dove la moda è un servizio e non più solo bene di consumo.
Ben vengano allora le piattaforme online che, come Vestiaire Collective e Vinted, rimettono in vendita vestiti di lusso e pret-a’-poter, sia usati che mai indossati, e le iniziative di firme blasonate come Valentino, che consente ai propri clienti la restituzione dei capi vintage della maison in cambio di voucher da spendere nelle loro boutique.
Infine, è opportuno ricordare che la sostenibilità di quest’industria non si misura solo in termini di emissioni di gas effetto serra. Un aspetto non secondario riguarda risvolti sociali, come il rispetto dei diritti nei processi produttivi e, a livello di politiche aziendali, il rispetto della diversità e dell’inclusione. In Bangladesh, nel 2013, il crollo dell’edificio del Rana Plaza provocò la morte di oltre mille addetti che, in condizioni di assoluto spregio per la tutela minima dei lavoratori, producevano abbigliamento per alcuni grandi marchi globali di fast fashion globali. Guardando invece alle tematiche di genere, in questo settore non brilla neppure l’Italia. La presenza di donne nei CdA delle aziende di moda resta ben al di sotto della media Europea: quasi 7 donne su 10 sono operaie, solo lo 0,9% arriva alla qualifica di quadro mentre uno sparuto 0,3% riesce a diventare dirigente. Un problema, questo, tornato drammaticamente attuale dopo le dichiarazioni shock dell’imprenditrice e stilista Elisabetta Franchi palesemente contraria ad assumere donne “under 40” e in età fertile!
A controbilanciare (almeno in parte) i cattivi esempi, ci sono per fortuna quei marchi che hanno adottato approcci più inclusivi, almeno a livello di comunicazione e immagine: sono sempre più numerose le aziende che bandiscono i corpi perfetti, in passerella e sulle copertine, preferendo affidare la loro immagine a persone reali e autentiche.
In conclusione, perché il settore della moda possa compiere un vero salto di qualità il cammino è ancora lungo e molto dipenderà anche dai nostri comportamenti e dalle nostre scelte d’acquisto. Allora, se prima di acquistare un nuovo vestito ci rendiamo conto che, per qualità e design, non lo indosseremo almeno trenta volte, meglio dar retta alla famosa campagna di sensibilizzazione #30wears di Livia Firth: lasciamolo sullo scaffale!
Marina De Antonellis Smimmo

Laureata in giurisprudenza all’università Federico II di Napoli, avvocato, ha esercitato la professione e ha lavorato come consulente per aziende pubbliche e private, tra un ciclo e l’altro di missioni all’estero del consorte. Nel 2018 ha conseguito un Master in Business Administration all’Università Cattolica di Buenos Aires e si è specializzata nella consulenza ad enti profit e non profit sui temi della sostenibilità e delle rendicontazioni non finanziarie (ESG). Ha vissuto in Tailandia, Marocco, Libano e Argentina. Come consigliere Acdmae promuove iniziative sulla sfida della sostenibilità e su Agenda 2030 e si occupa del gruppo Formazione e Lavoro. Prossima sede: Londra!